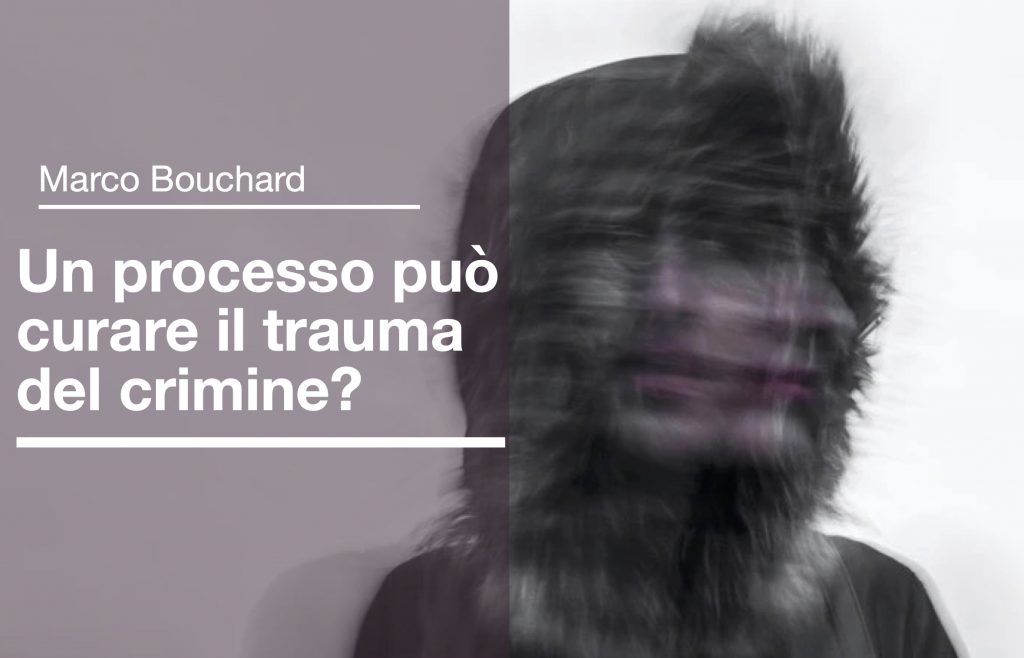di Marco Bouchard
Presidente di Rete Dafne Italia, rete nazionale di servizi per l’assistenza alle vittime di reato
Considerazioni su vittime, pena e riparazione alla luce del processo sulle stragi del 13 novembre 2015 a Parigi
Nella prospettiva di una disciplina organica della giustizia riparativa inserita nel disegno di legge per la riforma della giustizia penale è estremamente utile conoscere l’esperienza francese nel lavoro di assistenza alle vittime alla prova di quello che, in Francia, è considerato il processo del secolo. Attraverso alcune interviste raccolte da una giornalista radiofonica vengono approfonditi i temi delle possibilità riparatorie offerte dal processo penale, dell’importanza del lavoro di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo, degli effettivi bisogni delle vittime e del ruolo sostanzialmente marginale dell’incontro reo-vittima nella prospettiva riparativa.
L’emittente radiofonica francese RFI (Radio France Internationale), in occasione della prima udienza del 8 settembre scorso per gli attentati terroristici del 2015 al Bataclan, allo Stadio di Francia e nei caffè di Parigi (130 morti e migliaia di feriti), ha dedicato uno spazio di riflessione sulle possibilità che il processo penale contribuisca al percorso di cura dei traumatismi patiti dalle vittime e dai loro prossimi .
A discuterne sono stati chiamati Sid Abdellaoui, professore di psicologia sociale e del lavoro, esperto presso le Corti d’appello di Rouen e di Nancy nonché autore di un rapporto sulla giustizia riparativa in Francia commissionato dal Ministero della Giustizia francese; Olivia Mons, portavoce della Federazione francese France Victimes; Carole Damiani, psicologa e direttrice dell’Associazione Paris Aide aux victimes. A parte è stato intervistato Stéphane Sarrade, padre di una giovane vittima del Bataclan.
La giornalista, Raphaelle Constant, affronta subito il tema di fondo: «Un processo come questo – introduce – fa emergere una dimensione terapeutica. Come sono stati assistiti prima, durante e dopo il processo le vittime ferite e i cari delle persone scomparse? Cosa si aspettano queste vittime da un appuntamento come questo, quale percorso, quale sostegno sul piano della salute mentale può permettere di attenuare i sintomi dopo un simile trauma e oggi quale dispositivo esiste in questo sforzo di ricostruzione della vita del dopo per capire, ripristinare la fiducia e andare avanti, come si sente dire spesso, andare avanti piuttosto che guarire, e in nessun caso dimenticare?
Quasi nove mesi di processo, prima testimonianza a partire da lunedì prossimo (12 settembre), cinque settimane di udienze per le vittime, per un totale di 1800 parti civili».
- La preparazione delle parti civili al processo e la webradio per seguire il processo a distanza
La parola viene data innanzitutto a Olivia Mons che rappresenta France Victimes, un’associazione di secondo livello che raggruppa 130 associazioni locali costituite per garantire assistenza a tutte le vittime di reato. È stata fondata nel 1985 e svolge un ruolo fondamentale non solo per il sostegno e le informazioni sui diritti delle vittime di reati comuni ma anche in occasione di eventi straordinari come gli attentati terroristici. Strutture e operatori possono contare su un budget importante costituito grazie a prelievi sui premi assicurativi e gestito dal Ministero della Giustizia.
«Fin dal 14 novembre – osserva Olivia Mons – siamo stati sollecitati dal Ministero della giustizia e abbiamo predisposto l’intervento dell’insieme delle nostre 130 associazioni, perché bisogna immaginare che tutte queste persone vittime, le famiglie in lutto erano ovunque in Francia, in Europa e nel mondo e, all’interno delle nostre associazioni, avevamo giuristi, psicologi, assistenti sociali che si sono messi a disposizione, che hanno adottato un approccio proattivo, ossia, siamo andati verso queste persone e abbiamo rinnovato quest’offerta di servizio, naturalmente gratuito, per l’insieme di queste persone, affinché potessero afferrare la mano tesa verso di loro, un aiuto per liberare la propria parola, per ottenere delle informazioni giuridiche, e anche per poter cominciare a elaborare il dopo, che naturalmente non è concepibile e concepito nell’immediato. Ma abbiamo sciolto la matassa per tessere un nuovo legame innanzitutto con loro stessi, da un punto di vista psichico, e anche con la società e l’insieme del loro ambiente familiare e professionale…Per le oltre 3.000 vittime e parenti delle vittime che abbiamo incontrato in più di 5 anni, 30.000 incontri, abbiamo riscontrato molta apprensione, rabbia, è una tappa ma è chiaramente anche una prova. È una prova per tutte le persone che assisteranno a questo processo nei lunghi mesi di udienze, per tutte quelle che non possono venire ad assistere fisicamente e che avranno accesso a un dispositivo audio, di web radio, e siamo anche qui per quelle persone che non vogliono sentirne parlare… perché è insopportabile, perché non possono spostarsi fisicamente, e poi quelle che non vogliono sentirne parlare ma che ci saranno, si metteranno in una piccola grotta, al riparo dall’eco mediatica di questo processo. Saremo lì per ognuno e ognuna di loro».
La Corte d’assise con la collaborazione del Ministero ha ideato l’utilizzo di una webradio per permettere alle parti civili che non vogliono o non possono seguire in presenza il processo che è interamente registrato. Le parti civili avranno un codice secretato per accedere alla trasmissione il cui flusso prevede un differimento temporale di 30 minuti per consentire una interruzione, a tutela delle stesse vittime in ascolto, in caso di incidenti nel corso del dibattimento. Anche per le parti civili che seguono il processo a distanza è prevista un’assistenza psicologica. Unico difetto: non è prevista una traduzione simultanea per le lingue straniere.
La giornalista chiama in causa Sid Abdellaoui per le sue valutazioni su questo aspetto emotivo del processo.
«Si, in questo tipo di situazione, non si può trascurare, non si può sottovalutare la parte emotiva e, senza l’assunzione, il riconoscimento di quel che è all’origine di queste emozioni, nessuno può realmente ottenere un beneficio, credo sia importante al contempo riconoscere le proprie emozioni, riconoscere la sofferenza, la rabbia, l’odio generati da questi momenti che hanno determinato una rottura nella vita delle persone, delle vittime e anche nella vita delle famiglie di quanti sono sotto giudizio, degli autori. A un certo punto non si può più parlare solo di sanzioni, di pene, di esclusione, di relegazione, è importante riconoscere tutte le conseguenze che questo ha generato, riconoscerle, ascoltarle, prenderle in considerazione, nella costruzione di quel che darà l’impressione che la giustizia verrà fatta, sarà stata fatta».
Da un’inchiesta effettuata nel 2020 era infatti emerso che il 54% dei sopravvissuti e delle vittime presentava ancora – a distanza di cinque anni – i sintomi da stress post traumatico. Ci sono quindi persone che arrivano già fragili ed esposte ad emozioni particolarmente intense durante il processo.
«È la ragione per cui – interviene Olivia Mons – con l’Associazione parigina di France victimes, Paris aide aux victimes, abbiamo preparato l’insieme delle persone, delle parti civili, le abbiamo preparate in termini di informazione, perché quando sappiamo cosa accadrà si è un po’ meno preoccupati, le abbiamo preparate facendo delle visite preliminari per riconoscere i luoghi e sentirsi un po’ più in confidenza con i luoghi e per ridurre questo motivo di emozione.
Grazie a queste visite preparatorie, hanno potuto ottenere il badge d’accesso e quindi non saranno con tutto il resto delle parti in causa del processo, avranno un universo totalmente dedicato, avranno un badge e chi di loro non vuole parlare con i media indosserà un girocollo rosso, verde chi invece lo desidera. Durante la nostra preparazione, alcune hanno preso entrambi perché avevano ancora bisogno di riflettere alla propria posizione rispetto a questo universo mediatico».
- L’assistenza psicologica durante il processo
Anche durante tutto il processo è previsto un sostegno psicologico.
Questo è necessario – osserva Carole Damiani – «perché questo processo riattiverà nelle vittime il trauma psichico se erano direttamente presenti o il lutto per i parenti di chi è stato assassinato quel giorno e quindi è importante che ci siano delle persone, degli psicologi pronti ad aiutarli a superare e affrontare le emozioni. Da trent’anni abbiamo psicologi presenti nelle sale d’assise a sostegno delle parti civili ma è la prima volta che ce ne sono così tanti, così come c’è un dato inedito, ossia il numero di parti civili che saranno presenti.
Va osservato che i dibattimenti provocano sempre una forte emozione, non si resta indenni da quel che si sente, soprattutto quando si ascoltano delle testimonianze. È vero che per alcune persone è insopportabile, le riporta troppo alla propria sofferenza, quindi è importante che ci sia qualcuno ad aiutarle a parlarne, a sostenerle e a uscire».
Poi, «c’è anche il desiderio di ascoltare gli imputati – prosegue la psicologa – quel che hanno da dire, per loro è importante questa ricerca della verità, per capire quel che è potuto succedere. C’è poi un momento importante per le parti civili, le arringhe, le requisitorie.
Abbiamo organizzato tre riunioni preparatorie e garantito strutture di ascolto per tutta l’estate, quindi abbiamo effettivamente avuto il tempo di accogliere i loro timori, le loro angosce, i loro obiettivi, le loro ricerche ed è vero che sono in molti a porre la domanda: Perché. Innanzitutto: come, ossia come hanno potuto arrivare a fare simili atti senza esser individuati, è impressionante vedere le reti esistenti; e dall’altra parte, perché. Non è sicuro che riescano a trovare una risposta a queste domande ma è importante per loro».
Durante il processo l’assistenza alle vittime non riguarda solo le parti civili presenti ma anche quelle lontane, collegate o meno via webradio.
«Per chi assiste di persona – precisa Olivia Mons – effettivamente Carole e la sua squadra sono presenti alla Corte d’appello ma in tutta la Francia, quando le persone non sono a Parigi e seguiranno grazie alla webradio il processo, le associazioni (ne abbiamo 102) su tutto il territorio sono state raggiunte da persone che hanno accompagnato in questi anni le vittime. Quindi siamo già presenti per tutte le persone che avranno bisogno di discutere, parlare, avere altre informazioni e una linea dedicata per queste persone che assisteranno tramite la web radio al processo, una linea dedicata è stata attivata e sono a conoscenza di questo numero che possono chiamare ogni volta che vogliono».
Per le vittime il processo è un momento emotivamente forte dal punto di vista personale. Al tempo stesso un processo come questo genera un’attenzione mediatica impressionante.
«Effettivamente – secondo Sid Abdellaoui – ognuno lo vivrà come un momento intimo, molto personale, ma al contempo c’è una sorte comune che emergerà, perché le vittime si ritroveranno direttamente o indirettamente. Sentiranno tutte di appartenere a questo corpo ferito, a questo corpo colpito nel profondo della carne e, a partire da questo, si condivideranno le paure e le angosce e potranno esser contenute grazie al senso che ognuno troverà, questo processo permetterà anche di costruire e il dialogo che si aprirà probabilmente contribuirà già a superare lo scoglio. A mio parere, la parola è liberatrice, il processo è innanzitutto un evento che dà spazio all’oralità e quest’oralità deve essere il più possibile libera, sia all’interno della corte, sia all’esterno della corte, attraverso terzi, attraverso le associazioni, professionisti, bisogna restituire spazio all’oralità, affinché l’emozione non sia relegata, come dire, in un cassetto impossibile da ascoltare e da far vivere. Al tempo stesso, bisogna favorire strumenti e luoghi perché non diventi un teatro in cui si prova piacere a seguire, mentre ci sono realtà umane profondamente colpite».
Ma il processo è soprattutto una porta aperta verso il passato. Le vittime non hanno anche bisogno di voltar pagina?
«Non si volta pagina – dice Olivia Mons – hanno cicatrici indelebili, ma in compenso questo non impedisce, come diceva, di andare avanti. Parlavamo di prove ma la prova è anche una tappa, permette a tutte queste persone… l’oralità, il fatto di poter deporre, che la giustizia è presa in considerazione con la possibilità per tutte le parti civili che desiderano esprimersi di poterlo fare, di poter offrire delle informazioni alla giustizia ma anche di fronte agli imputati, sulle ripercussioni psicologiche, familiari, professionali, sociali che questi attentati hanno avuto su di loro, su loro stessi e le loro famiglie. Questo è estremamente importante. È un racconto individuale ma anche un racconto che diventa collettivo. Parlavamo di comunità, Carole parlava di comunità, in effetti abbiamo questa comunità di vittime con degli individui e queste comunità hanno potuto ritrovarsi anche all’interno di associazioni di vittime, in cui effettivamente la parola tra pari è stata una fonte di conforto».
- Testimoniare la perdita di un figlio in tempi e modi prestabiliti
Al processo verrà garantita la parola alle vittime e ai loro cari. La Corte d’Assise ha stabilito di dedicare alle vittime cinque settimane d’udienza a partire dal 28 settembre. La testimonianza dei sopravvissuti avrà il tempo contato: trenta minuti a testa.
Tra questi verrà sentito Stéphan Sarrade, padre di Hugo, ucciso a 23 anni al Bataclan. Anche lui è stato assistito e preparato da Raphaelle Constant.
«In realtà – precisa Stéphane Sarrade – da sei anni sappiamo che è un lungo percorso, è il percorso del lutto. Questo lutto è particolare nella misura in cui, benché sia un lutto personale, perdere un figlio è qualcosa di molto pesante, ma è inoltre un lutto collettivo. Ossia, abbiamo anche dovuto sostenere psicologicamente il fatto che Hugo facesse parte di un collettivo. Va anche considerato che è un lutto che ci pone delle domande sul senso, già perdere un figlio non ha senso, perché siamo sulla terra per seppellire i genitori e i nonni, ma non si seppelliscono i figli. Le circostanze in cui si inserisce questo lutto, personalmente, mi hanno estremamente turbato. Per sei anni ho tentato, e ancora ci provo, di trovare un senso, ho tentato di comprendere quel che porta al processo di radicalizzazione, quel che ha spinto dei giovani francesi, nati in Francia, a prendere le armi e recarsi al Bataclan per uccidere degli innocenti tra cui mio figlio; avevano la stessa età, 23 anni. Quindi, tutti questi elementi sono stati particolarmente sconvolgenti, mi hanno condotto a farmi molte domande, ho avuto un sostegno psicologico che mi è stato proposto dalla cellula di crisi degli attentati, un professionista che per due anni mi ha aiutato a tentare di esprimere a parole quello che sentivo, il modo in cui potevo andare avanti, il modo in cui potevo gestire al tempo stesso lutto personale e lutto collettivo. Per esempio, non sono mai riuscito ad andare al Bataclan, neanche per vedere la lapide che è stata apposta in memoria delle vittime. Mi sono chiesto se era normale reagire così. Il mio terapista mi ha detto “Ascolti, se non se la sente, non lo faccia. Non c’è alcun problema”. Sei anni dopo, la questione è che imparo a vivere con l’assenza di mio figlio, è la cosa più difficile, è forse quello di cui accuso di più gli autori: “In aggiunta a tutto, mi avete insegnato a vivere senza mio figlio”.
Penso siano due o tre mesi che sento arrivare questa forte pressione psicologica e abbiamo una riunione con il giudice incaricato del caso, che ci mostrerà l’aula delle udienze, ci illustrerà un po’ la logistica. In quel momento, il processo diventa realtà. Mi sono preparato al fatto che, ad ogni modo, si ritornerà sulla questione e si entrerà nei dettagli. Si, sono in apprensione, sarà un pesante carico emotivo ma so che è necessario, bisogna passare da lì per poter in seguito ricostruirsi e andare oltre. Rifiuto di aver paura, per una semplice ragione: i terroristi sono lì per terrorizzarci, quindi se abbiamo paura, loro hanno vinto. Quindi, il fatto stesso di aver paura è come dargli ragione. Ecco, mi sforzo a non provare paura. Da sei anni».
Ma la vittima può realmente coltivare delle aspettative di riparazione del trauma?
«Penso – aggiunge Stéphane Sarrade – che ho la fortuna di vivere in una democrazia, che non mi aspetto molto da questo processo in termini di risposte, di questioni tecniche, su quel che è accaduto. Non so neanche se gli imputati prenderanno la parola né se vorranno partecipare. Ad essere importante per me è anche il fatto di avere la percezione che il nostro Stato, la nostra Repubblica, la nostra Giustizia chiedono che ci sia l’incarnazione di quanto accaduto, anche se gli autori diretti sono morti, almeno quelli del primo nucleo sono tutti morti, ma quelli che rimangono hanno una parte di responsabilità, seppur meno elevata. Non mi aspetto pene spettacolari, siamo una Repubblica, non c’è ragione perché paghino per degli atti che non hanno commesso, seppur sono loro sul banco degli accusati. Non mi aspetto necessariamente questi elementi in termini di riparazione, in termini di pena. Poi, questo processo sarà molto lungo, 8 settembre – 22 aprile, con un’estrema esposizione mediatica, se ne parlerà molto e penso che al termine di questo processo non se ne parlerà più, nel senso che successivamente passeremo nella storia. Gli attentati del 13 novembre, come anche l’attentato di Charlie, tutti questi elementi diventeranno elementi della nostra storia, della nostra storia comune e noi, le famiglie, dovremo continuare il nostro lavoro di lutto, continuare a fare dei passi avanti. Ecco, questo processo per me è la fine di qualcosa e l’inizio di qualcos’altro. Questo processo non riparerà il trauma, non uscirò da questo processo dicendo: “Ci siamo, è finita, sono guarito, passo ad altro”. È una cosa molto più complessa, fa parte dell’equazione, fa parte degli elementi. Questo processo è uno degli elementi che costellano il mio percorso di resilienza. Aspettavo questo processo e credo sia un punto importante nella mia traiettoria, nel mio cammino personale».
Stéphane Sarrade si è attivato per l’istituzione di una borsa di studio in memoria di suo figlio, la borsa Jiyuu Hugo Sarrade, che permetterà a uno studente di partire e sostenere uno stage in Giappone, paese adorato dal ragazzo. Jiyuu, che significa “libertà” in giapponese.
- Il processo per la vittima è una prova non uno strumento di cura, tantomeno di guarigione. L’assistenza dopo il processo
Per Sid Abdellaoui il processo dal punto di vista delle vittime è, innanzitutto, una prova, «una prova perché è psicologicamente ed emotivamente costosa, è costosa anche sul piano cognitivo, perché ci sono tantissime cose che verranno riattivate, bisogna trattare tutto questo e perciò l’accompagnamento è imprescindibile, il sostegno, sia esso sociale o professionale, è indispensabile. Non bisogna negare che i traumi possono avere degli effetti perenni, cronici, a vita, se non si fa niente le cose possono essere ancora più gravi, ossia ci possono essere degli scompensi fino a sindromi quasi irreversibili. Quindi bisogna pensarci, ora, domani e dopodomani, perché spesso si pensa al domani ma non al periodo compreso tra i 5 e i 10 anni successivi, per non dire 20 anni; penso siano degli eventi che lasceranno necessariamente delle tracce, quindi è prima di tutto una prova e deve anche essere una fonte di salvezza, una fonte di salvezza per cercare di ripristinare un equilibrio, quello che è necessario per andare avanti, per continuare con queste ferite ma anche con degli elementi che si saranno potuti incamerare di comprensione, di significato… abbiamo citato il concetto di perdono, potremo riparlarne, ma è un aspetto intimo che riguarda l’ambito personale… alcuni vogliono poter perdonare per andare avanti ma per questo hanno bisogno di materia, hanno bisogno di capire, dare senso a quel che è capitato, alle responsabilità del passaggio all’azione. Bisogna inoltre dare la precedenza alla dignità umana, perché tutto questo riguarda infine l’umanità, un’umanità non sempre auspicabile, ma si può passare solo da questa via, non è possibile fare diversamente, non è possibile ripristinare un equilibrio che sia personale o sociale se non consideriamo che, all’origine delle nostre sofferenze, è un frutto stesso della nostra umanità».
Stéphane Sarrade ha utilizzato prima il termine di resilienza. Allora: la giustizia può giudicare, poi punire, ma deve anche offrire alle vittime questa possibilità di resilienza?
«No – sostiene Olivia Mons – la offre attraverso lo stesso racconto che le vittime potranno fare davanti alla giustizia. Quindi è un elemento, infine, per poter raccontare il proprio dolore e la propria sofferenza, è senza dubbio un elemento di resilienza. Ora non c’è un’ingiunzione alla guarigione, non c’è un’ingiunzione alla resilienza e questo è importante…ed è la ragione per cui la rete France Victimes è perenne, era presente, è presente e lo sarà nel futuro…»
Ma un processo può aiutare a guarire?
«No – ritiene la psicologa Carole Damiani – non guarisce, come dire, non è una cura, le cure sono dentro di sé, nell’intimità. In compenso, il processo può aiutare a superare una tappa. Per le vittime, qualsiasi cosa ne dicano, dopo il processo, non necessariamente nell’immediato, perché è troppo recente, ma in un secondo tempo, alcune settimane, alcuni mesi dopo, si tratta di una tappa, certo dolorosa ma fondamentale per loro e nel loro percorso. Non saranno state guarite, se il trauma è sempre lì, se il lutto non è stato elaborato, non sarà il processo a farlo. Tuttavia, può alleggerire comunque e dà uno scopo, ossia, alcuni dicono “Con il processo andrà meglio, ecc.” Quando arriva la fase di disillusione, subito dopo, potranno farci qualcosa, potranno elaborare e si potrà assistere a una sutura, un percorso.
Abbiamo preso in carico queste vittime a partire dal novembre 2015, ne abbiamo seguite diverse decine, se non centinaia. Il trauma non è fondamentalmente diverso nella sua espressione sintomatica rispetto agli altri traumi, per esempio di stupro, troviamo le ripetizioni, gli evitamenti fobici, l’ipervigilanza. I sintomi sono molto simili quando siamo di fronte a un trauma psichico…
In compenso, ad essere diverso è tutto il vissuto legato a questo evento, ossia, il senso di colpa, che non si riscontra allo stesso modo nello stupro e in un attentato terroristico, la rabbia, che non si esprime nello stesso modo. È questo vissuto che ne determina la specificità e il fatto di sentirsi colpiti in maniera intenzionale, pur non essendo realmente il bersaglio.
Ci sono alcune vittime che non desiderano niente, ossia niente di quel che gli possa essere offerto. È vero che dal 2015, la procura ci ha dato l’incarico e dobbiamo contattare regolarmente le vittime per garantirgli quello di cui hanno bisogno, fare il punto e alcune hanno detto che non lo volevano, né sostegno psicologico, né presenza al processo. Alcune persone ci raccontano di non guardare più le informazioni dopo il 2015, per essere sicuri di non doverci ripensare, a volte è troppo doloroso e noi rispettiamo questa posizione anche se pensiamo che sarebbe bene almeno avere uno scambio.
Abbiamo delle procedure proattive ma quello che osserviamo è che a volte le altre vittime hanno un peso maggiore rispetto a noi, professionisti, avendo vissuto la stessa cosa, e a volte le vittime preferiscono essere in contatto con persone che hanno vissuto la stessa cosa. Non dev’essere semplicemente una condivisione, è necessario andare oltre questa semplice condivisione. Ma, a volte, le altre vittime sono una via d’accesso.
Il trauma rimette in discussione i valori fondamentali che saldano una comunità, ossia … non si crede più nella giustizia, non si crede più nella comunità, non si crede più nella sicurezza, ed è vero che esiste questo senso di abbandono che fa sì che queste vittime non trovano che altre vittime per contrastare questo senso di abbandono. Eppure, oggi, ci sono manifestazioni di solidarietà che permettono di lottare contro, pur non essendo sempre semplice».
L’assistenza alle vittime è fondamentale anche dopo il processo.
«Dopo il processo – prosegue la psicologa – ci si accorge di una forte disillusione. È già stato svolto un lavoro di informazione ma c’è sempre questa aspettativa e, per alcune vittime, ce ne sono troppe, soprattutto se non hanno intrapreso un percorso psicologico o terapeutico prima, si aspettano di essere guarite dal processo.
Quella che considero importante è la cosiddetta terza fase, ossia, prima li prepariamo, siamo lì durante, ma non dimentichiamo la terza fase, quella in cui possiamo affrontare la spiegazione, l’elaborazione che aiuta nel dopo e spesso viene dimenticata».
- La giustizia riparativa
In questo quadro quale ruolo può effettivamente svolgere la giustizia riparativa?
Secondo Sid Abdelaoui la giustizia riparativa può assumere diverse forme «coinvolgere attori più o meno numerosi, alla base è necessario che l’autore riconosca i fatti. È il minimo, ci si aspetta che riconosca almeno in parte la propria responsabilità nello svolgimento dei fatti.
Ci sono casi in cui gli incontri tra vittime e autori aprono all’idea di un possibile dialogo, di incontro con l’altro, con il fatto di essere animati dall’umanità, dunque l’autore, la vittima accettano insieme di dialogare…accompagnati da un professionista che vigilerà sul contesto, che si assicurerà che l’uno e l’altro condividano lo stesso obiettivo, al tempo stesso di restituire senso, umanità, magari anche di darsi sollievo, di alleviare la sofferenza per andare avanti. Quindi, molto spesso a monte c’è un grosso lavoro realizzato dal terzo mediatore, dal terzo facilitatore, come lo si voglia chiamare…
In Francia c’è stata l’introduzione della giustizia riparativa con una legge piuttosto recente, del 2014, la legge Taubira, che ha un approccio rivoluzionario, che non ha ancora sufficientemente dato luogo a una professionalizzazione di questa funzione. Quindi la maggior parte delle persone che hanno intrapreso questa via viene da una formazione giuridica, ci sono sempre più assistenti sociali, consiglieri per l’inserimento sociale e per la messa alla prova, psicologi, che si formano per elaborare programmi di giustizia riparativa e arricchiscono questo corpo di mediatori e facilitatori. L’idea è avere un approccio plurale, al contempo incentrato sul diritto, sulla sociologia, sulla psicologia, sul trauma, anche sulla comunicazione, sulle problematiche della mediazione, perché la mediazione è un’arte, è un approccio complesso, non basta mettere delle persone… è veramente l’individuazione di quel che a un certo punto diventa una fonte di legame o, al contrario, si rischia l’abbandono da parte di una delle due persone. Perché se non è impostata in maniera abbastanza rigorosa, c’è il rischio che la persona abbandoni. Se la persona abbandona è probabilmente peggio che se non si fosse mai presentata».
«In realtà – soggiunge Olivia Mons – in Francia France victimes è stata tra i precursori degli incontri tra detenuti e vittime… da una parte quel che Sid Abdellaoui definiva “mediazione riparativa” tra l’autore e la vittima che si conoscono, che sono legati dagli stessi fatti e da un’altra parte incontri che chiamiamo anonimi, di gruppo sia in detenzione, sia al di fuori della prigione, con persone condannate e persone vittime che non si conoscono.
È per ogni tipo di reato, ad ogni modo in quel che è stato concepito dalla legge e poi sostenuto da un discreto numero di professionisti, come il professore Cario, che ha fondato l’Istituto francese sulla giustizia riparativa, ci troviamo veramente in uno spazio di dialogo, tra persone che si conoscono e non si conoscono, in modo… sia un incontro e un dialogo possibile, sia su diverse settimane…»
Il ricorso alla giustizia riparativa è un diritto dal 2014, «quindi – prosegue Olivia Mons – le persone ne sono informate, devono esserne informate. Non sono sempre informate ma devono essere informate e, si, possiamo ricevere dei rifiuti ma la maggior parte delle volte sappiamo spiegare quel che può offrire in termini di liberazione della parola, di riumanizzazione del proprio vissuto…».
È uno spazio complementare alla giustizia penale, ma può intervenire anche se non c’è un processo, quando ci sono dei casi prescritti o archiviati. Allo stato attuale non ci sono ancora dati precisi e il rifiuto ad accedere a programmi di giustizia riparativa può intervenire tanto dalla vittima quanto dall’autore dei fatti.
Il processo non risponde a tutte le domande.
Nel lavoro di ricerca – insiste Sid Abdellaoui – si è registrata «una grossa differenza tra il periodo che precede la sentenza e quello che la segue. Dopo la sentenza, siamo di fronte a persone che hanno bisogno di ripristinare un legame, di restaurare il dialogo. E quando questo legame esiste, la risposta che gli offriamo in termini di giustizia riparativa è spesso accolta favorevolmente da queste persone. Se questi bisogni non vengono espressi dopo la sentenza, dopo che la giustizia classica si è pronunciata, spesso troviamo un’esitazione e in queste occasioni la spiegazione può essere utile. Nella fase prima della sentenza ad essere importante è la preparazione…la giustizia riparativa è innanzitutto uno strumento che favorisce la ricostruzione individuale, quindi siamo proiettati su un contesto individuale, che solo successivamente servirà al legame sociale, alla società ma è innanzitutto individualizzare uno sguardo, un approccio, contrariamente a quello che fa la giustizia classica. La giustizia classica si interessa in primo luogo della riparazione materiale…».
Le interviste si possono ascoltare in podcast al https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20210908-un-proc%C3%A8s-peut-il-gu%C3%A9rir-un-traumatisme
Le parti virgolettate contengono la trascrizione e traduzione delle interviste da parte di Alice Campetti, traduttrice de Le Monde diplomatique per il manifesto.