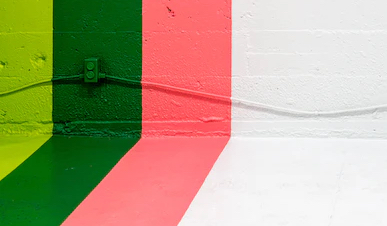Parma, 11 maggio 2023
Cronaca di una giornata con la redazione di Ristretti Orizzonti nel carcere di Parma
Di Marco Bouchard
Arrivo a Parma con lo stesso treno di Ornella, la fondatrice della redazione di Ristretti Orizzonti nel carcere di Padova. Ci ricongiungiamo a Carla che ci aspetta in stazione. Raggiungiamo Manlio e Paolo, anche loro in attesa e che, a detta di Carla, stanno discutendo di perdono.
Arriviamo velocemente alla nostra meta, il carcere, poco all’esterno della città. Durante il viaggio, Paolo ci fa sapere che nei prossimi giorni tornerà a Parma per portarsi al cimitero della Villetta dove è sepolta la sorella Emanuela insieme al marito, entrambi uccisi a Palermo nell’attentato del 3 settembre del 1982.
Dopo le formalità dell’accesso raggiungiamo la sede della redazione, fondata nel 2016 – sull’esempio di quella di Padova – proprio da Carla, con un gruppo di detenuti in Alta sicurezza.
Avevo incontrato questo gruppo di detenuti nel mese di febbraio. È un piacere reciproco rivedersi. La volta scorsa si era creata un’atmosfera di profonda empatia anche grazie alla presenza di Luciana, perché aveva proposto la sua esperienza di giudice civile, convinto sostenitore della mediazione, e di autore di racconti per l’infanzia e di progetti nelle scuole per una educazione non violenta alla conflittualità. Scherziamo sulla loro delusione per la sua assenza.
Manlio e Paolo sono, tecnicamente, le vittime. Manlio rifiuta questa etichetta. Preferisce quella di sopravvissuto. Sono seduti, insieme a me, su un lato di una lunga tavolata. Di fronte a noi, prendono posto tutti i detenuti provenienti dalle quattro regioni dell’Italia meridionale devastate dalla criminalità organizzata. Mancano due detenuti, entrambi in cura per gravi patologie. Nino e Claudio sono pronti a prendere appunti sui loro portatili. Vittime e detenuti si fronteggiano benché tra loro non ci sia un crimine che li accomuni, non ci sono ferite inferte o subite che reclamano un coinvolgimento emotivo diretto. Gli uni per gli altri sono dei sostituti dell’Altro protagonista dei fatti che li ha spinti, oggi, a frequentarsi per qualche ora. Né per gli uni né per gli altri è la prima volta che si consuma questo rito dell’incontro indiretto. Più sfilati, ci sono due giornalisti che “registrano” questo finale di percorso sulla giustizia riparativa. Alla testa della tavolata Carla coordina la discussione, accanto a Ornella e una poliziotta straordinaria, colta e empatica.
E Carla apre il confronto con una domanda preannunciata: perché Paolo e Manlio cercano l’incontro con chi ha commesso, per natura e gravità, un crimine identico a quello che ha mutato irreversibilmente le loro vite?
Paolo è stato a lungo un medico nelle zone di guerra e, dopo l’uccisione della sorella, la morte come esperienza privata si è mescolata alla morte come esperienza lavorativa e professionale: solo nei reparti di ostetricia la spirale di morte veniva interrotta dalla certezza di vita e dalla speranza di futuro. Il trauma della perdita dovuto alla morte della persona cara ha determinato, infatti, lo stravolgimento del tempo a venire. Nulla è stato più come si era immaginato.
L’incontro con altre vittime è stato un passaggio fondamentale, anche se in questo modo si è confrontato soprattutto con delle reazioni non condivise, improntate al risentimento e alla vendetta. O meglio: lui avrebbe voluto stare bene e dare un senso alla vita che la morte aveva compromesso.
Nella ricerca di ritrovare una vita soddisfacente, il raccontare il proprio dolore, non solo a chi poteva condividerlo ma a chi lo aveva causato, gli ha restituito quel senso a lungo desiderato. Esprimerlo è stato un modo per farlo uscire da sé, privarsene di fronte a chi, detenuto, lo sperimentava attraverso la perdita della libertà, l’incapacitazione e la deresponsabilizzazione. L’incontro con l’Altro detenuto è stata esperienza di un dolore speculare in cui poter donare il proprio racconto dell’offesa e delle modalità per dismettere la condizione di vittima. La possibilità di rappresentare al detenuto la dimensione e la misura, concreta ed emotiva, del dolore causato ha costituito per lui un’occasione di responsabilizzazione che gli ha effettivamente restituito riparazione.
La scelta di Manlio di varcare la soglia del carcere e incontrare i detenuti ha tutt’altra origine. Manlio è un sopravvissuto di una strage politica, voluta dal terrorismo nero e a lungo priva di una verità giudiziaria per i depistaggi e i vuoti d’indagine. Nella strage ha perso la moglie, gli amici e i compagni dell’impegno sindacale e politico. La frattura esistenziale è stata netta. I fatti, inoltre, non avevano nulla di privato perché la bomba era stata messa per colpire una manifestazione antifascista. Inizialmente, la reazione al vuoto lo ha portato a girare l’Italia per testimoniare il rifiuto della violenza e l’esigenza di marcare la diversità rispetto a chi aveva colpito. Ma è stato in un viaggio a Cuba, una vacanza che avrebbe dovuto trascorrere con la moglie, che ha avvertito tutto il peso dell’assenza di Livia, un’assenza che era costantemente presente. Era un’epoca in cui le vittime non contavano niente, non c’era neppure un minimo di associazionismo. Come per Paolo il solo incontro tra vittime si prestava costantemente al rischio di creare un’identità vittimaria e, poi, di essere strumentalizzati.
Inoltre i processi, indipendentemente dai loro tempi biblici, non lo avrebbero aiutato a capire chi erano davvero gli autori e i perché di quelle scelte di vita e delle loro azioni criminali. Solo oggi, a distanza di 50 anni, si celebra il processo nei confronti di Marco Toffoloni, presunto esecutore materiale della strage, con il rito minorile perché all’epoca non aveva ancora compiuto i 18 anni.
Manlio aveva bisogno di un volto e di capire, in qualche modo, il perché di quella strage, perché tutta quella violenza, attraverso persone in carne ed ossa che offrissero una spiegazione plausibile. L’esperienza dell’incontro, durante alcuni anni, con diverse vittime del terrorismo e di alcuni protagonisti della lotta armata degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, gli ha finalmente permesso di ottenere delle risposte. A partire da quell’esperienza ha proseguito il suo impegno di testimone e sopravvissuto, continuando a varcare la soglia di diverse carceri.
Io mi sono seduto tra Manlio e Paolo, di fronte a sette persone rei confessi, in alcuni casi, di molti omicidi in contesti di criminalità organizzata, reduci da anni di detenzione in regime di “41 bis”.
Cosa potevo dire se non che la mia storia personale e professionale di magistrato stava proprio sul crinale delle loro vite, tra chi aveva causato e chi aveva subito sofferenze irreversibili. Certo: non ero lì per caso. In fondo la mia vita professionale è stata un tutt’uno con il mio interesse per un metodo riparativo, tanto più utile quanto più rivolto alle giovani vite travolte da piccole o grandi offese.
Mi è sembrato utile, però, a quel punto del nostro incontro, fare una precisazione.
Un crimine, prima ancora di essere tale e rientrare in una definizione giuridica, è un fatto. O meglio: è un fatto percepito come ingiusto dalla vittima o da chi in suo luogo lo percepisce come tale. È quel fatto che definisce la vittima, la sua condizione, il suo statuto: non l’accertamento che, eventualmente, verrà compiuto da un’autorità giudiziaria. La vittima può ritenersi tale anche contro un accertamento giudiziario che la delude e ha dei diritti, in quanto tale, ad essere assistita. Per la persona indicata come autore non è il fatto che determina la sua condizione, il suo statuto ma un atto d’accusa: una denuncia, un rinvio a giudizio, una condanna. Se manca quest’atto, se manca la dimensione pubblica, l’offesa – ammesso che l’autore la ritenga tale – è solo un fatto che riguarda la sua coscienza.
Un fatto non si cancella, un atto si può annullare o revocare.
Questa differenza segna tutte le successive differenze tra chi si sente vittima e chi viene incolpato e, eventualmente, condannato. I bisogni, i desideri, le aspettative sono completamente diversi. La vittima pretende “riconoscimento” di sé e dell’accaduto, l’accusato pretende rispetto dei suoi diritti e delle garanzie che lo tutelano dalle insidie delle procedure e dalla violenza che lo stato può legittimamente (non sempre) infliggere.
Il riparare è un’esigenza primaria della vittima ed è per questo che chiede riconoscimento. Per l’accusato l’esigenza del riparare è del tutto secondaria: insorge solo di fronte ad un’assunzione di responsabilità: ricercata o imposta.
Per questo l’incontro, come dimostrano le storie di tutti i presenti, non può che essere frutto di un lavoro lungo e selettivo. Tra le vittime prevale l’impotenza o il risentimento perché superare la condizione vittimaria non è facile e perché incontrare l’altro richiede un’assunzione di responsabilità “sociali” non così diffuse. Per l’accusato e, soprattutto per il detenuto, il riparare comporta una rinuncia ad un atteggiamento difensivo che riguarda innanzitutto l’istituzione che lo accusa e che lo minaccia.
Ma le vittime – insinua Carla – sono tutte uguali?
No di certo – sostiene Gianfranco. Le persone che ha ammazzato erano come lui, forse peggio di lui. Non possono considerarsi vittime. O, comunque, non sono vittime innocenti come, al contrario, lo sono i morti di Piazza della Loggia. La morte inflitta negli scontri a fuoco della criminalità organizzata è una morte certa evitata: quella propria. Non è proprio d’accordo Fabio, giovanissimo autore di una terribile striscia omicidiaria. Il suo intervento mi stupisce perché nel nostro incontro precedente sosteneva un’altra tesi. Allora, era stato chiaro nell’escludere la possibilità di un incontro con i famigliari delle sue vittime. In quel caso avrebbe dovuto rivelare la crudeltà e la malvagità dei loro cari. Oggi precisa che non intendeva togliere agli uccisi la loro qualità di vittime ma esprimere la sua preoccupazione per il rischio di infliggere ulteriore sofferenza ai famigliari, eventualmente ignari delle imprese criminali del defunto.
Nel mio lato del tavolo le posizioni sono compatte: non ci sono vittime buone e cattive. La morte e il dolore esigono il rispetto comunque inflitti. Non posso, però, non osservare che la distinzione tra vittime colpevoli e vittime innocenti è proprio lo Stato a farla: e questa colpevolezza della vittima si estende ai famigliari fino al quarto grado di chi è sottoposto a procedimento per reati di mafia. Anche se estranei e all’oscuro dell’attività criminale dell’ucciso non possono essere beneficiari delle elargizioni previste dalla legge per le vittime innocenti.
Ma Gianfranco insiste sulla diversità perché la diversità sta nel tipo di reati, nella motivazione, nelle ragioni dell’azione. Lui non avrebbe mai potuto uccidere persone innocenti, non avrebbe mai potuto mettere una bomba nel cestino dei rifiuti di una piazza affollata da manifestanti. Lui, in quella piazza, sarebbe stato dalla parte degli antifascisti.
E qui Manlio, stimolato da Carla, introduce un tema a lui caro. In realtà nessuno può dirsi innocente e tutti sono chiamati alla responsabilità. Certo: lui non avrebbe mai fatto del male neppure ad una mosca ma, nella ricostruzione della memoria dei fatti e dei contesti del passato, non può neppure dirsi estraneo al clima di violenza degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Anche lui partecipava, con gli slogan, le urla, l’odio verso il nemico a quell’impercettibile sviluppo dalla prova di forza allo scontro violento. Anche per questo il suo impegno, dopo la strage, è stato dedicato a testimoniare la non violenza e a valorizzare il patrimonio di cultura democratica accumulato nell’esperienza sindacale. E questa è stata la grande differenza emersa negli anni del confronto con i protagonisti della lotta armata rispetto alla loro scelta violenta e mortifera.
Forse qui, davvero, si profila il confine invalicabile tra il crimine “mafioso” e il terrorismo rosso. Oggi l’incontro tra diversi reduci della lotta armata di “sinistra” e i sopravvissuti dei loro delitti è stato “favorito” da una risalente comune idealità o, quanto meno, da una comune politicità del loro agire. Entrambi avevano uno sguardo rivolto all’avvenire, implacabilmente oscurato dai primi.
Per i delitti di mafia manca questa base dell’incontro e la distinzione tra vittime colpevoli e innocenti aggiunge ostacoli poco superabili. Su questo terreno, forse, sono molto più utili dei percorsi autonomi cercando, soprattutto, di soddisfare l’esigenza primaria della vittima di vedersi riconosciuta e non abbandonata come accade normalmente.
Il viaggio verso la legalità dell’uomo e della donna di “mafia” sconta un coefficiente di difficoltà particolarmente elevato. In carcere – lo dice Paolo con parole moderate ma affilate per il suo uditorio – ci finiscono i soldati. È raro che ci finiscano i burattinai. Ma questo non esime da responsabilità i soldati.
Ne è perfettamente cosciente Nino che ha consapevolmente ucciso che gli ha portato via il padre.
È un passaggio cruciale per Gianfranco perché la sua vita criminale è iniziata e finita al tempo della sua gioventù, affascinato dal miraggio della ricchezza, del potere sugli altri, dall’ammirazione generale di cui godevano i piccoli e grandi boss. Per molti è stata una strada obbligata, inevitabile, frutto di un’educazione privata del senso di legalità. Nell’aula che ci accoglie le sue parole sono percepite quasi come una giustificazione, un appello alla sua ignoranza e irresponsabilità.
Ancora una volta Paolo interviene di fronte a questa rinuncia della coscienza di sé. E ricorre all’esempio di un detenuto appena scarcerato dopo 45 anni di detenzione, da tempo frequentato dentro le mura del penitenziario di Milano. Si era messo a scrivere poesie e leggendogliele si era messo a piangere dalla disperazione per quegli anni buttati via, per quella vita senza senso: 45 anni buttati via per niente. Per niente – ha ripetuto più volte Paolo. E non è vero che a 18-20 anni si è costretti ad uccidere. Si è pienamente capaci di dare la morte. È una scelta. Ed è una responsabilità che comporta molte conseguenze: non solo per chi viene ucciso ma anche per i propri famigliari e l’ambiente in cui si vive.
Gianfranco è colpito ma reagisce. Lui è consapevole del disastro che ha provocato ma la sua vita è cambiata, non è più il criminale, ora è un’altra persona. Da tempo, da molto tempo. E, si chiede, il mondo che lo ha portato a fare delle scelte sbagliate è così cambiato oggi? Per questo ha preferito cercare una via più spirituale per affrontare i vuoti imposti dal carcere e le incertezze del proprio futuro. “Cosa devo ancora dimostrare?” – ci chiede.
E come dargli torto, mi viene da pensare. La vita del detenuto, soprattutto la loro, è sotto costante osservazione. Si susseguono psicologi e criminologi – osserva Claudio – a cui riepilogare, ogni volta, la propria storia, le proprie riflessioni, le consapevolezze raggiunte.
Ci prendiamo una pausa per uno spuntino quando Nino mi si avvicina per sottolineare che ognuno di loro viene da contesti famigliari e ambientali diversi e non tutti percepiscono oggi il passato criminale come ad un segmento archiviato e ineluttabile. Alcuni di loro avevano avuto un’infanzia serena e un’adolescenza addirittura promettente, molto lontana dalle attività criminali.
Dopo la pausa si aggregano tre professori di liceo (filosofia, lettere antiche e religione) che hanno favorito incontri tra detenuti e i loro alunni. Hanno anche avuto la possibilità di assistere ad un dialogo tra Agnese Moro e Grazia Grena.
Rimane un tema spinoso da affrontare. Mentre Paolo riesce a pronunciare la parola perdono sia pure circondata da alcune condizioni, Manlio è molto più restio e preferisce dei termini più complessi. A me pare, in realtà, che finiscano con l’esprimere lo stesso concetto perché il perdono in sé non è un atto che permetta di vivere meglio o di arrivare alla verità che è, invece, un valore ricercato dalle vittime. Mi sembra che entrambi preferiscano l’obiettivo e il senso di una possibile trasformazione che coinvolga gli uni e gli altri anche lungo tragitti diversi. Laddove opera la trasformazione e quando il dialogo si profila come possibile motore e esito di quel cambiamento, allora il perdono può indossare un qualche vestito presentabile.
Secondo Claudio tutto questo richiede però la prospettiva di una vita non solo liberata ma anche, effettivamente, libera.
Un grande filosofo del novecento sosteneva che il vero perdono è solo quello incondizionato che perdona l’imperdonabile. Tuttavia, per dirla con Hanna Arendt, il perdono è l’unica risorsa possibile per venire a capo di un passato irreversibile.
Se vogliamo ammetterlo come orizzonte possibile per regolare i rapporti tra i sopravvissuti di eventi tragici provocati da una volontà colpevole, allora dobbiamo fissare almeno due condizioni ineliminabili. Primo: il perdono deve essere richiesto e non offerto gratuitamente. Secondo: nessuno è autorizzato a concedere il perdono in nome d’altri e per offese causate ad altri.
Alla fine la riunione si è sciolta con una doppia consapevolezza. Le vittime spesso si riparano da sole, hanno le risorse per risistemare passabilmente la loro vita. Quando invece viene sconvolta necessitano innanzitutto di riparo, di assistenza per i bisogni più diversi. In alcuni casi intraprendono – come Manlio e Paolo – un cammino riparativo che comporta una responsabilità pubblica e il confronto con l’Altro. Ma chi rimane nel risentimento non va lasciato solo, preda del desiderio vendicativo.
Non so se l’incontro di oggi è un esempio di giustizia riparativa. Di certo condivido con Ornella un punto fermo: non sarà la giustizia riparativa a rendere più umano il processo e la pena. Anzi: la giustizia riparativa potrà affermarsi solo nella misura in cui la giustizia ordinaria, nei suoi meandri procedurali e con le misure penali, rispetti la dignità delle persone coinvolte, la loro legittima aspirazione alla libertà e risponda ai canoni del senso supremo di umanità.